Gianlucamotto
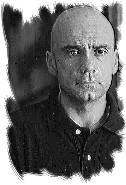

Menu principale:
 “Niente è come sembra niente è come appare” è il verso della canzone omonima di Franco Battiato che ben esemplifica anche quest’ultima sperimentazione di Gianluca Motto in cui siamo invitati a osservare il dato visibile per intuirne la parte intima. Affrontando il tema della natura animale, il pittore, infatti, è riuscito a catturare una realtà che a noi sfugge, in una pittura complessa e coinvolgente, presentando gli animali in singolari e suggestive sfaccettature: i diversi soggetti si presentano in una serie di immagini che ribaltano il pensiero comune e assottigliano il confine tra ciò che crediamo e ciò che veramente è. Motto è partito dal presupposto che osservando il comportamento di un essere vivente si vede la sua anima ed è riuscito a eliminare il pregiudizio secondo cui solo l’uomo possiede la spiritualità mentre gli animali hanno soltanto l’istinto facendo emergere dai suoi quadri le emozioni e i sentimenti di alcune specie. Non è una teoria recente quella che indica gli animali come possessori di un’anima perché è noto che la cultura greca li facesse partecipare al ciclo della metempsicosi: il filosofo Empedocle dichiarava di essere stato nelle sue vite precedenti oltre che un ragazzo e una ragazza anche un uccello e un pesce mentre Pitagora aveva già sostenuto che, nelle molte rinascite personali, le anime sono “costrette a incarnarsi in successive carceri corporee, umane e bestiali, a causa di una colpa originaria da espiarsi sino alla finale purificazione o catarsi”. Questo pensiero occidentale è, da sempre, stato preceduto e affiancato anche dalle dottrine orientali perché l’idea della reincarnazione, presente fin dai primordi dell’umanità, evidenzia come l’uomo, l’animale e il pianeta stesso su cui viviamo siano uniti da una medesima esperienza. Il luogo comune secondo cui agli animali non viene riconosciuto lo stato di persona in quanto considerati alla stregua di oggetti nasce, nel XVII secolo, dal presupposto che essi non pensino e non ragionino secondo la filosofia cartesiana che li considera macchine perché non sono in grado di parlare. È stato invece rivelato dagli studi di etologia che alcuni animali, al pari degli uomini, utilizzino un loro linguaggio, provino dolore, piacere ed emozioni, ma questa non è ancora un’opinione accettata da tutti ed è difficile che le persone conoscano i veri comportamenti di alcune specie e, quindi, Motto ha lavorato per sovvertire questa voluta incapacità di comprensione offrendo allo spettatore precisi indizi pittorici da decodificare. In un ritrovato paesaggio, l’artista ha ambientato i diversi animali tra frammenti poetici, incastonati in una scrittura graffiante, e li ha posizionati in modo da afferrare il suono della solitudine e del malinconico mistero dell’opera “I fiori del male” di Charles Baudelaire: il letterato francese, ancora una volta, è il medium con cui il pittore sottolinea, in una staticità apparente, il trascorrere dell’esistenza, condizionata da accelerazioni e da rallentamenti consoni alle situazioni e agli stati d’animo rappresentati. In tutti i dipinti la calma dei luoghi è un terreno pieno di incognite da svelare perché la realtà esterna offre, oltre la soglia del visibile, quel mondo interno da cui parte la domanda invisibile di Motto: quali considerazioni ci inducono a pensare che il leone sia feroce mentre il pettirosso docile? Il leone, il più forte del mondo animale, è nella savana il re in quanto è il predatore incontrastato, ma è un felino socievole e la storia ci insegna che, pe
“Niente è come sembra niente è come appare” è il verso della canzone omonima di Franco Battiato che ben esemplifica anche quest’ultima sperimentazione di Gianluca Motto in cui siamo invitati a osservare il dato visibile per intuirne la parte intima. Affrontando il tema della natura animale, il pittore, infatti, è riuscito a catturare una realtà che a noi sfugge, in una pittura complessa e coinvolgente, presentando gli animali in singolari e suggestive sfaccettature: i diversi soggetti si presentano in una serie di immagini che ribaltano il pensiero comune e assottigliano il confine tra ciò che crediamo e ciò che veramente è. Motto è partito dal presupposto che osservando il comportamento di un essere vivente si vede la sua anima ed è riuscito a eliminare il pregiudizio secondo cui solo l’uomo possiede la spiritualità mentre gli animali hanno soltanto l’istinto facendo emergere dai suoi quadri le emozioni e i sentimenti di alcune specie. Non è una teoria recente quella che indica gli animali come possessori di un’anima perché è noto che la cultura greca li facesse partecipare al ciclo della metempsicosi: il filosofo Empedocle dichiarava di essere stato nelle sue vite precedenti oltre che un ragazzo e una ragazza anche un uccello e un pesce mentre Pitagora aveva già sostenuto che, nelle molte rinascite personali, le anime sono “costrette a incarnarsi in successive carceri corporee, umane e bestiali, a causa di una colpa originaria da espiarsi sino alla finale purificazione o catarsi”. Questo pensiero occidentale è, da sempre, stato preceduto e affiancato anche dalle dottrine orientali perché l’idea della reincarnazione, presente fin dai primordi dell’umanità, evidenzia come l’uomo, l’animale e il pianeta stesso su cui viviamo siano uniti da una medesima esperienza. Il luogo comune secondo cui agli animali non viene riconosciuto lo stato di persona in quanto considerati alla stregua di oggetti nasce, nel XVII secolo, dal presupposto che essi non pensino e non ragionino secondo la filosofia cartesiana che li considera macchine perché non sono in grado di parlare. È stato invece rivelato dagli studi di etologia che alcuni animali, al pari degli uomini, utilizzino un loro linguaggio, provino dolore, piacere ed emozioni, ma questa non è ancora un’opinione accettata da tutti ed è difficile che le persone conoscano i veri comportamenti di alcune specie e, quindi, Motto ha lavorato per sovvertire questa voluta incapacità di comprensione offrendo allo spettatore precisi indizi pittorici da decodificare. In un ritrovato paesaggio, l’artista ha ambientato i diversi animali tra frammenti poetici, incastonati in una scrittura graffiante, e li ha posizionati in modo da afferrare il suono della solitudine e del malinconico mistero dell’opera “I fiori del male” di Charles Baudelaire: il letterato francese, ancora una volta, è il medium con cui il pittore sottolinea, in una staticità apparente, il trascorrere dell’esistenza, condizionata da accelerazioni e da rallentamenti consoni alle situazioni e agli stati d’animo rappresentati. In tutti i dipinti la calma dei luoghi è un terreno pieno di incognite da svelare perché la realtà esterna offre, oltre la soglia del visibile, quel mondo interno da cui parte la domanda invisibile di Motto: quali considerazioni ci inducono a pensare che il leone sia feroce mentre il pettirosso docile? Il leone, il più forte del mondo animale, è nella savana il re in quanto è il predatore incontrastato, ma è un felino socievole e la storia ci insegna che, pe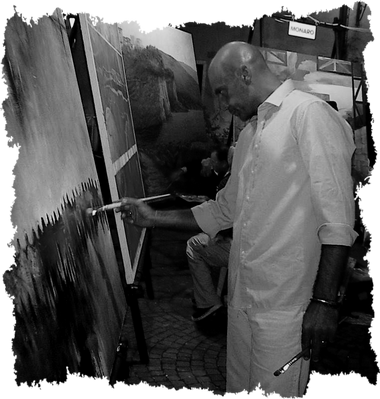 r anni, i Masai hanno convissuto con i leoni senza che questi li attaccassero mentre il pettirosso, pur di dimensioni ridotte, è conosciuto per il suo comportamento spavaldo ed estremamente combattivo nei confronti dei suoi simili e degli intrusi penetrati nel suo territorio. Non è un caso, quindi, che, nelle opere di Motto, l’uomo appare, scompare e poi riappare in rapporto con questi piccoli uccelli e non con i leoni o gli altri predatori perché gli uomini sono gli unici animali da mettere in cattività per cantare al posto dei pettirossi perché la nostra specie in crisi ha perso il controllo di sé e del mondo. La figura umana, quasi trascurata, è evocata, infatti, attraverso icone della
r anni, i Masai hanno convissuto con i leoni senza che questi li attaccassero mentre il pettirosso, pur di dimensioni ridotte, è conosciuto per il suo comportamento spavaldo ed estremamente combattivo nei confronti dei suoi simili e degli intrusi penetrati nel suo territorio. Non è un caso, quindi, che, nelle opere di Motto, l’uomo appare, scompare e poi riappare in rapporto con questi piccoli uccelli e non con i leoni o gli altri predatori perché gli uomini sono gli unici animali da mettere in cattività per cantare al posto dei pettirossi perché la nostra specie in crisi ha perso il controllo di sé e del mondo. La figura umana, quasi trascurata, è evocata, infatti, attraverso icone dellasperimentazione precedente quali le ballerine e le nuvole che emergono nel paesaggio in cui solo gli animali manifestano quel soffio vitale che dovrebbe animare ogni essere vivente. In una pittura fatta di colori vivi e pulsanti con una luce che penetra le ombre delle gabbie fisiche e concettuali e squarcia le nuvole silenziose, il filo conduttore della riflessione di Motto ci viene evocato anche nelle carte intelate in cui il pavone, abbagliante per la bellezza del suo piumaggio, sappiamo essere in realtà poligamo e aggressivo nei confronti degli altri animali da cortile a differenza dell’aquila, uno dei più potenti rapaci, fedele al proprio compagno per la vita e combattiva solo per ragioni specifiche e contingenti. L’artista, inoltre, ci incalza a osservare anche il comportamento degli elefanti e sembra chiederci se possiamo essere proprio sicuri che siano privi di anima perché si sa che quando un elefante si allontana dal gruppo anche solo per qualche ora, al suo ritorno, viene riaccolto con una cerimonia di benvenuto, che se uno di loro sta morendo gli altri gli si stringono intorno sforzandosi in tutti i modi di sostenerlo affinché non cada, come se volessero prolungarne a ogni costo la vita e comunque vegliano il cadavere, lo ricoprono con rami, strappandoli dagli alberi vicini, con erbe e frasche e seppelliscono non solo i membri della propria specie, ma anche i cadaveri di altre specie compresi gli uomini. Questi fatti non possono non mettere in crisi la presuntuosa certezza che solo la specie umana sia pensante e capace di provare sgomento e di interrogarsi sul significato della morte e, quindi, l’artista evidenzia dati capaci di stimolare associazioni di idee in sequenze interiori in cui il pensiero emerge dal quadro e s’impone nella nostra mente. Le forme, nate dall’essenzialità del colore, rivelano ciò che i singoli elementi non dicono e restituiscono all’immagine le sue infinite interpretazioni e, quindi, questi animali, domestici o selvaggi, raffigurati con precisione nel loro comportamento abituale ma all’interno di una dimensione prettamente psichica, tracciano una realtà in cui scorgiamo la verità nascosta dentro e dietro le apparenze perché il leone che cammina pigramente, il pettirosso che intona la sua melodia, il pavone che fa la ruota, l’aquila in volo e l’elefante che barrisce mettono a colloquio due anime: quella dell’animale e quella dell’artista ovvero l’estraniante condizione umana. È in questa pittura da toccare, da ascoltare, da leggere e da vedere con la mente che Motto riesce a rivelare un’idea che sembra non esserci, ma che c’è e che vive dentro di noi fornendoci i mezzi per capirla e interpretarla perché, attraverso i suoi dipinti, riesce a evocare quel momento preciso e ineffabile in cui la conoscenza finalmente incontra la coscienza.
Francesca Mariani